Racconto breve
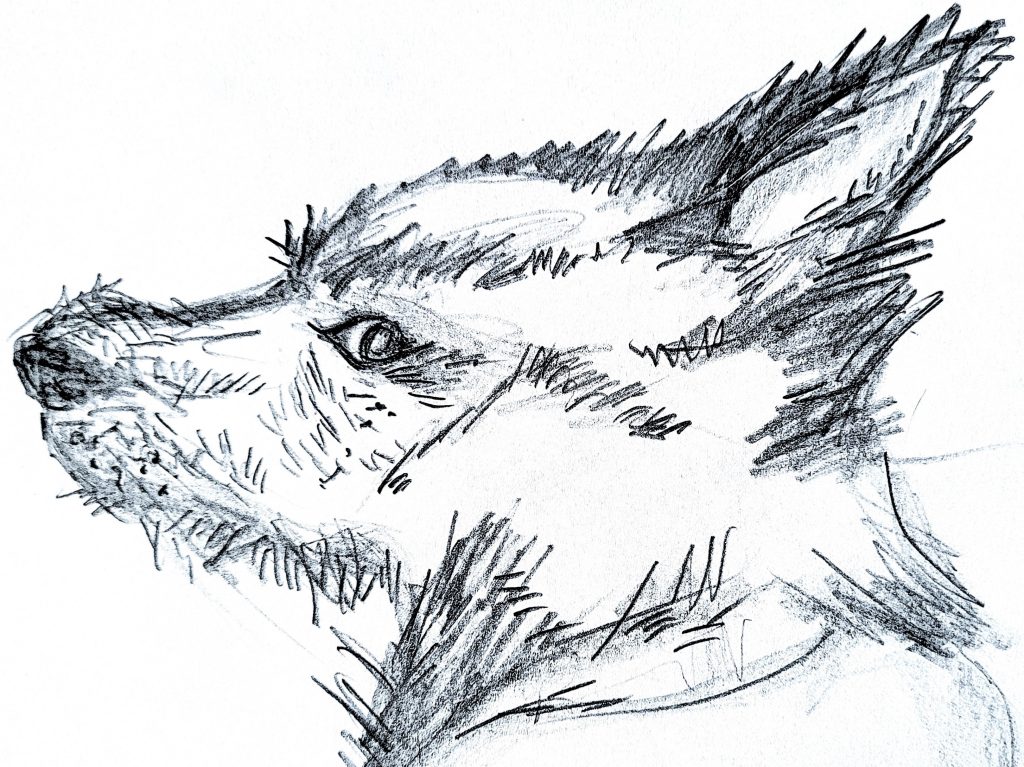
Racconto breve
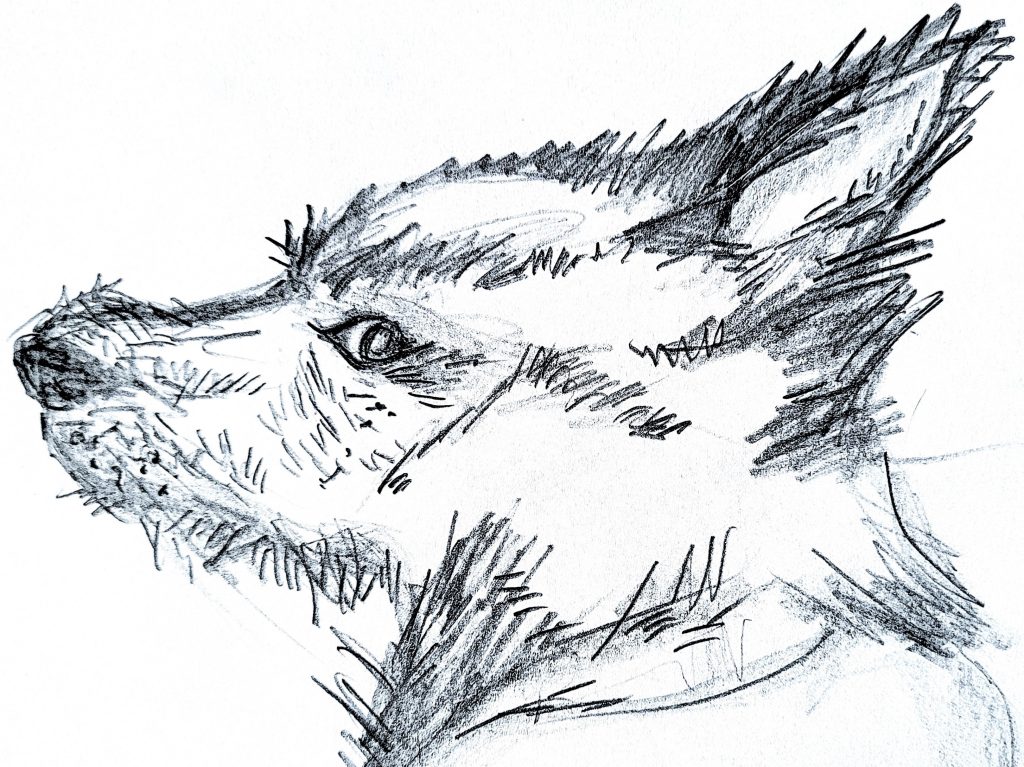
Gustavo Pane, il poeta dei conigli morti.
Base romanzo
di Matteo Beltrami
Gustavo Pane detto cièncièn, Marradi, appennino Tosco-Romagnolo, 11 luglio 1944
Gustavo scappa giù dal colle attraverso il bosco buio. Prova a non far rumore ma ansima forte. Rotola e rovina come il tronco di un piccolo castagno sradicato da una frana. La notte è ovunque ed è famelica, non lascia scampo alla luna, la trascina nel buio per tentare di spegnerla. Sembra riuscirci. Rimbomba un pesante acquazzone il cui suono soffoca i suoi gemiti di terrore. A lui non importa dei sentieri, né dei burroni di pietre taglienti, né delle cadute. Non contano una mano fratturata, uno zigomo lacerato, il fucile maledetto che si è perso nel fogliame viscido già all’inizio della fuga. Gli importa soltanto di sparire, di non farsi raggiungere e segue la rotta che farebbe un masso in caduta libera, staccatosi dalla montagna durante una mortifera ghiacciata.
Continua a pensare al fatto che è il suo compleanno. Non vorrebbe che lo fosse. Lo voleva fino a qualche ora prima, ma non lo vorrebbe più. È un chiodo fisso che gli punge il cranio, il suo compleanno. E sa già che lo sarà per sempre. Quel giorno ha compiuto 14 anni, gli altri partigiani gli hanno riempito le scapole di pacche solenni, ma lui se le vorrebbe pulire via di dosso. Si possono pulire vie le pacche che non si sono apprezzate? Ripensa a quelle pacche e grida mentre inciampa in un’altra radice, passandosi le mani sulle spalle come a voler scacciare via una vespa di terra. Atterra con la bocca spalancata in una smorfia in bilico fra l’apnea protratta e la morte. Folle e disperato morde il fango del bosco con violenza animale, come fosse un cinghiale. Tossisce e vomita, ma poi si rimpinza la bocca di altro pantano e stavolta lo manda giù, è folle. Vorrebbe diventare terra, sparire, vorrebbe diventare vermi e non rinascere più. Si strozza con un altro pugno di fango, grida ancora mentre un tuono esplode, il suono del suo grido è soffocato dalla melma. Porta la mano alla bocca e si guarda attorno, gli occhi sgranati, si sente predato e si ricorda del perché è lì. Scuote forte la testa, se la picchia con un pugno ossuto, vomita fango, poi riprende la sua fuga verso il basso dell’appennino. Non vuole essere preso, non vuole essere visto, vuole solo sparire dalla vista e dalla memoria di ogni anima del paese. A sua volta vorrebbe scordarsi di se stesso.
Gli hanno fatto un regalo tremendo, un regalo per sempre. Lui lo sentiva che quelle erano pacche di guerra e le voleva scansare. Nell’apnea i pensieri si susseguono forsennati. Solo adesso capisce che quelle più che pacche erano spinte. Dice a sé stesso che ci sono pacche che le senti tenerti lì, nel sicuro riparo dell’affetto di chi te le dà. Le pacche di quel mattino invece erano diverse, lo incalzavano, facendolo avanzare inesorabilmente verso premature virilità, che non avrebbe dovuto accettare. Avrebbe voluto dire di non spingere, che di regali non ne voleva, che c’era la guerra e lui aveva perso tutti a parte la mamma e che dunque non c’era proprio niente da festeggiare, ma erano tutti così grandi e rabbiosi, gli altri partigiani. Non lo avrebbero neppure udito. Sputavano e bevevano e non avevano tempo, né cura, per i tentennamenti di un bambino.
A 10 anni suo nonno, un uomo tutt’altro che quieto, gli aveva fatto ammazzare il primo coniglio. Era stata una sorta di iniziazione, un rito ordalico riservato ai maschi della sua famiglia. Coniglio, gallina, agnello, vitello, vacca, toro. Questo sarebbe stato l’ordine della macellazione da apprendere, nel corso degli anni. Una prova ammantata da un clima austero che non lasciava scampo alle esitazioni. Poi i tedeschi erano arrivati e il bestiame era sparito.
Ma il giorno dei suoi 10 anni il nonno gli aveva porto un bastone tozzo e lo aveva fissato negli occhi in modo severo prima di parlare:
- Devi tenere il legno con due mani e i piedi un po’ larghi. Quando colpisci butta fuori l’aria. Lo devi prendere appena dietro l’orecchio, ma forte.
- Ma se non muore subito? – Si era preoccupato Gustavo.
- Morirà subito.
- E come mai?
- Sono già troppe domande. – Il nonno si era già seccato. – E comunque ho scelto un coniglio giovane, ha le ossa che si spezzano subito. Adesso preparati che lo vado a prendere e lo tengo dalle zampe.
Il nonno era un uomo grosso, pesante in tutto e per tutto, con uno stomaco duro sempre fasciato da qualche canottiera sporca di vino, sangue o tabacco, che ungevano di una puzza brusca anche la sua pelle e il suo rumoroso respiro. Aveva le gambe grosse, nodose e arcuate, piene di cicatrici. Diceva che se l’era fatte tutte con la lama della motozappa, che rinculava quando colpiva le pietre. “Quella bastarda”. La chiamava così. Aveva dei piedi lunghi e larghi, con tutte le unghie spezzate e contuse, alcune nere, alcune gialle. Le sue mani erano come palanche consumate, dure e callose, per uccidere i conigli usava quelle, non i bastoni. In qualche modo Gustavo, a 10 anni, avrebbe voluto diventare come il nonno, ma quel giorno avrebbe intuito che non sarebbe stato possibile. Entro cinque o sei mesi ogni caso non lo avrebbe più sopportato. Aggiungendo qualche mese ancora, poi, il nonno sarebbe stato ammazzato con una raffica di mp40 da quattro giovani biondi mai visti prima, venuti dalla Germania.
A parte una strana sensazione di malinconia, comunque, con il coniglio era andato tutto come voleva il nonno. Gustavo era stagno per la sua età. Aveva picchiato forte e la bestia era morta subito, dopo un ultimo fremito.
- Tutto bene, puoi iniziare a imparare il mestiere, auguri. – Gli aveva confermato il nonno passandogli un bicchiere colmo di vino e una sigaretta già accesa.
Era estate, il sole stava scendendo e davanti a loro si spalancava un panorama collinare pregno di una luce vanigliata e sanguigna. Quello era il Mugello. Il nonno spaccò un’anguria che aveva tenuto tutto il giorno in un secchio calato nell’acqua gelida, sul fondo del pozzo. Lui affondò la faccia in un pezzo del frutto e chiuse gli occhi, sopraffatto dalla freschezza zuccherina. Cercò di bere il vino imponendosi una certa gioia, facendo caso all’effetto ubriacante che gli abbassò un po’ le palpebre e gli accarezzò l’anima con mano ignota. Si era immaginato a lungo quel momento, ma il nonno non sembrava davvero felice per lui e quella malinconia non se ne andava. Tutto ciò non lo lasciò indifferente, così prese a rimuginarci. Un tiro di paglia, un colpo di tosse, silenzio.
- Sei triste di cosa? – Gli aveva chiesto il nonno bucando le zampe del coniglio con due ganci acuminati che penzolavano da una trave della stalla.
- Triste nonno? E di cosa? No, no! – Rispose celermente con un’altra domanda, la voce un po’ stridula e le gote paonazze. Scosse insieme la testa e una mano con le piccole dita chiuse a grappolo.
Poi tacquero ancora, mentre Gustavo tossicchiava fra fiotti di fumo andato di traverso e finiva il vino per schiarirsi la gola, il nonno staccava la pelle e la testa del coniglio dal resto del corpo, usando un coltello corto. I muscoli delle sue braccia guizzavano mentre faceva esplodere degli strattoni violenti. La pelliccia del coniglio di strappava dalle carni con un suono che Gustavo non si sarebbe mai dimenticato. Poi il nonno lanciò pelle e testa in un cestone di vimini. Lui ne aveva seguito la traiettoria e non poteva fare a meno di fissarle, perché il manto, ora orribilmente scomposto e distante dalla carne dove fino a poco prima era radicato, era lucente e di un castano bellissimo. Gli occhi guardavano in su e gli sembravano sul punto di esprimere ancora qualcosa, ma non capiva cosa. Pensò, con la sua dolce mente da bambino, che forse sentiva un nodo in gola perché gli era venuta la nostalgia di quando il coniglio era ancora vivo. Rivide la paura inconsolabile che aveva avuto quando lo avevano preso dalla gabbia e sollevato dalle zampe posteriori. Che razza di pensieri erano mai quelli? Nella mente prese a immaginare dove fosse adesso e cosa avesse ancora da dire. Lui avrebbe avuto paura di andarci, in quel luogo lontano. Ma di quale luogo si trattava? C’era qualcuno che glielo poteva raccontare? Non di certo il nonno. Risentì il suono della pelle che centimetro dopo centimetro di staccava dalla carne, strattonata con forza brutale. Era stato un suono strisciante, squarciante, e gli era parso incredibile che il coniglio non sentisse più dolore. Quanto altrove poteva mandarti la morte? Pensò. Scosse appena la testa per scacciare chissà cosa.
Poi una frase lacerò con inconsapevole maestria la nebulosa di parole e immagini nella quale fluttuava trasportato dalla fantasia, l’alcool e il tabacco. Una frase che gli cambiò la vita:
- Fai attenzione a non diventare il poeta dei conigli morti, cièncièn. – Gli aveva detto il nonno all’improvviso, con il tono un po’ biascicato, mentre recideva il ventre dell’animale con una sigaretta in bocca.
E lui allora capì di essere stato visto. Non soltanto guardato, ma proprio visto. Aveva osservato il nonno, a sua volta, per verificare se ridesse. Certo, ridere rideva, ma era più un ghigno beffardo che altro, inoltre non gli aveva stropicciato la faccia e i capelli come quando scherzava e allora aveva pensato che il nonno fosse soprattutto serio. Fai attenzione, gli aveva detto. Sì, era serio, lo aveva rimproverato e non da ultimo aveva camuffato quel rimprovero con un ghigno, per timore di ferirlo. Certo, adesso c’era arrivato, il nonno pensava di lui che fosse troppo sensibile, oppure matto, la prova non era stata superata. Guardò i campi di grano. Fai attenzione, pensò. Un monito, addirittura. Fu così che lì, fra il coniglio spellato che penzolava, il barbera, il fumo e l’odore estivo dell’appenino, prese a pensare di come sarebbe stata la vita di un poeta dei conigli morti. Non gli venne in mente niente di più futile al mondo. Non lo disse, ma ebbe paura di esser preso per poeta, o folle, o debole, perché in paese c’era qualche poeta ma non li prendevano mai sul serio e alcuni erano strani, bevevano e piangevano in silenzio, da soli, ficcati in fondo alle osterie.
- Vieni qui, guarda – aveva proseguito il nonno richiamando la sua attenzione e facendolo avvicinare. – Quando tiri via le budella devi stare attendo a non bucare questo sacchettino verde. È la bile, è piena di merda amara. Non la devi bucare. Se la buchi la carne del coniglio la puoi dare ai cani. –
- Merda amara. Va bene. – mormorò catturato da quella strana pallina viscida color dell’alga.
- Ti fa schifo? –
- – Disse alzando le spalle, ed era vero.
Quella stessa sera la nonna aveva cucinato il coniglio in umido, con i porcini e la polenta, ci avevano mangiato in dieci. La nonna aveva scherzato e canticchiato per tutto il tempo della preparazione e quando si era messa a tavola aveva stappato un fiasco dandogli l’idea di non pensare a nient’altro all’infuori dei suoi commensali, a roba come il fiasco, il taglio del pane, i fuochi. Lui proseguiva le elucubrazioni che l’uccisione della sua prima bestia gli aveva fatto esplodere in testa. Iniziò a credere che alcuni i conigli li ammazzavano, li cucinavamo e tutto si concludeva così, per bene, fino al coniglio successivo. Altri invece ci scrivevano su poesie, o rimanevano a fissarli da morti ponendosi domande strambe. Il nonno sapeva che lui faceva parte del secondo gruppo, probabilmente lo avrebbe raccontato agli uomini del paese alla prossima ciucca, giù all’osteria vicina al ponte. Invidiò i nonni. Invidiò tutti i commensali, anche i suoi genitori, ma al contempo sentiva di non volere essere come loro, e per la prima volta si sentì solo. Solo ma con qualcun altro dentro, perché certi strani pensieri era come se li facesse lui, ma non fossero del tutto suoi, erano come un rumore di fondo involontario. Fu devastante e magnifico, perché si sentiva incompreso ma al contempo libero di coltivare in gran segreto da tutti qualsiasi tipo di pensiero. E quel sorprendente nodo in gola che sentiva ancora, gli faceva venire voglia di piangere e lo faceva sentire vivo.
Non aveva più parlato, certo il coniglio era buono, ma non gli aveva fatto andar giù quel groppo. Dopo la cena si era infilato nella sua branda ad ascoltare i grilli che fuori cantavano fra l’erba alta. Aveva pianto e gli era piaciuto. Sprofondando nei suoi respiri, già stordito dalla stanchezza della giornata e della malinconia, udì una frase che come un ceppo di faggio che cade sul pavimento di legno rimbombò per tutta la casa:
- Ti dico che non è buono! – Ed era stata la voce del nonno a pronunciarla, biascicando dal tanto vino.
- Shhh! Che dormono! – Gli aveva risposto sua mamma sibilando rabbiosa.
Gustavo poi si addormentò, non scoprì mai se il nonno si riferisse a lui, ma quella frase non se la scordò mai. Buono come abile? Oppure buono come perbene? Faceva una differenza enorme. Doveva sentirsi cattivo allora? Ma come maldestro oppure come immorale? Oppure stava semplicemente parlando del coniglio, del vino, o del tabacco?
E quella mattina, per il suo quattordicesimo compleanno, ormai lontano nel tempo dal suo primo coniglio e con il nonno decomposto e accartocciato in posa innaturale sbattuto a marcire in una fossa comune, addosso a suo padre, i suoi fratelli maggiori, due zii e due cugini, i partigiani sbandati gli avevano fatto sparare allo stomaco di un tizio con addosso l’uniforme nemica. Lo avevano catturato all’alba, quando erano usciti dalle grotte per cagare. Stava cagando anche il tizio, Marco Reggiani si chiamava, aggrappato a un tronco per non cadere all’indietro. Loro erano più in alto, sul pendio boschivo, lo avevano visto e gli avevano sparato senza indugio, colpendolo a una gamba. L’uomo aveva mollato la presa ed era rotolato per alcuni metri in discesa. Lo avevano raggiunto, colpito in testa con i calci dei fucili, poi gli avevano tirato su le braghe. A qualcuno era venuta l’idea di portarlo a Gustavo come regalo. Faceva pena un po’ a tutti quel Gustavo. Lo avevano incrociato nel bosco sopra il paese e lui aveva iniziato a seguirli. Era piccolino e aveva gli occhi ingenui, un’espressione concentrata come a non voler sbagliare le parole, le mosse. Gli avevano spiegato di non essere un gruppo partigiano ufficiale, ma solo una banda clandestina di fuggiaschi e scartati, che volevano fare la loro parte.
- Siete gli unici partigiani che vedo qua attorno. – Aveva risposto Gustavo.
- Ci siamo fatti la nostra di brigata, siamo una specie di distaccamento. E noi di tregue non ne facciamo. Se vuoi ti portiamo su in cresta da quelli della Garibaldi, oppure rimani con noi sbandati qui attorno, magari fai fuori qualcuno. – Gli avevano detto.
- Mi hanno fucilato i fratelli, il papà e tutti gli altri uomini. E quelli della Garibaldi non mi vogliono, dicono che devo badare ad altro. – La sua risposta suonò come una decisione.
Gli avevano risposto che se voleva poteva raggiungerli, indicandogli dove, di preciso. Gustavo la notte era scappato di casa, perché la mamma non lo avrebbe mai lasciato andare. Si era unito agli altri scappati e in paese non ci era più tornato, ma sapeva che la mamma doveva sicuramente star male. I grandi dicevano che la guerra sarebbe finita in inverno, allora lui pensava che mancavano pochi mesi, si sarebbe fatto perdonare in quel momento e che sarebbe stato bellissimo rivederla da eroe.
Il mattino del suo quattordicesimo compleanno, pacca dopo pacca, gli avevano ripetuto che era il suo giorno. Gli avevano fatto vedere il prigioniero e lui lo aveva guardato con scarso coraggio. Avrà avuto vent’anni quel Marco, era italiano e parlava con l’accento di quelle parti. Gli altri gli sputavano sulle gambe e sulla schiena e gli davano del fascista. Il prigioniero continuava a ripetere con tono persuasivo che soltanto i suoi ufficiali erano tedeschi e che mica tutti potevano scegliere di fare i partigiani. Saltellava sulla gamba sinistra, la destra era tutta impataccata di sangue e feci. Gli altri lo sfottevano perché era caduto sulla propria merda. Il prigioniero scuoteva la testa con e appoggiava le mani sulle canne dei fucili di tutti, aveva la pelle abbronzata e i capelli nerissimi, ancora fradici e pettinati all’indietro, diceva di aver fatto il bagno nel fiume e che da quelle parti c’erano fiumi bellissimi. Ogni tanto si guardava la ferita sulla coscia destra e chiedeva di un dottore.
- Che se ci pensi bene ragazzo, questa non è nemmeno la nostra guerra. – Gli aveva urlato guardandolo dritto negli occhi. – Fatemi prigioniero e la finiamo no? Tempo al tempo, finisce anche la guerra sai? Stanno già arrivando gli americani e gli inglesi e tutti, e dai, che lo sapete. Prima dal dottore a curarci i malanni e poi tutti al fiume! Eh ragazzo, facciamo così? Non lo prendere questo regalo, dai. – Blaterava pervaso dal panico.
E poi si rivolse agli altri, ansimando a bassa voce.
- Questa non è nemmeno la vostra di guerra! Oh, ma siete tutti ammattiti? Ma scherziamo? Come regalo di compleanno? Per questo ragazzetto qua? Io? Ma che regalo sono? Ma così gli rovinate la vita. Ma non lo vedete che è solo…–
E poi basta, più niente, le armi di tutti si erano abbassate, tutti avevano smesso di sputare e sghignazzare, perché Gustavo si era preso il regalo e aveva tuonato una fucilata di quelle storiche. Il colpo aveva sbrindellato il petto dell’uomo, che ora non viveva più. Una fucilata di quelle storiche buone, almeno per un pugno di ore, almeno per quello che sembrava, o che sperava.
- Bravo! Bravo Cièncièn! Se vai avanti così ci liberi tutti entro Ognissanti! – Lo avevano acclamato mentre accendevano altre sigarette e versavano altri grappini.
Ma la storia di quella fucilata era diventata tremenda dal mezzogiorno, quando sul crinale erano iniziate ad arrivare se staffette con le voci della rappresaglia del battaglione italo-tedesco, giù in paese.
Quelli del distaccamento avevano buttato il fascista morto in un dirupo, ricoprendo il cadavere alla bell’e meglio, con foglie e pietre che avevano trovato lì attorno. I suoi commilitoni però lo aspettavano, avevano sentito gli spari e lui non era mai tornato. Lo avevano cercato con i cani, ne avevano ritrovato il cadavere e subito dopo erano scesi in paese a rastrellare i contadini che vedevano per strada o sui poderi a mietere. Dapprima avevano echeggiato i suoni delle raffiche di mitragliatrici, rimbalzando fra le rocce di tutta la valle, poi le staffette erano risalite dai sentieri per riportare la conta degli ammazzati.
- Stanno facendo una strage, una rappresaglia per il fascista morto. Hanno ammazzato anche il Don. I tedeschi sono come impazziti. -Ansimavano sbattendosi disperatamente i pantaloni con i cappelli.
E lui che aveva appena compiuto 14 anni, si aspettava altre pacche sulle sue scapole secche, ma non ne arrivarono più, quel compleanno era finito, anche se sarebbe durato per sempre, maledetto per sempre. I partigiani presero anche loro a sbattersi i pantaloni con i cappelli, e bevvero e fumarono ancora di più, incattiviti. Ben presto alcuni iniziarono perfino a guardarlo di sbieco. A Gustavo tutto iniziò a sembrare un incubo paralizzante e infernale, quegli uomini gli sembravano mostruosamente iracondi. Alcuni uomini partirono per un’altra caccia, irragionevoli come cani da pastore idrofobi che rispondono in branco alla sfida dei lupi. Ne ammazzarono ancora uno con un colpo in faccia, ne ferirono un altro dandogli prima fuoco e poi buttandolo giù da una scarpata. Stavolta erano tedeschi. Uno sbandato prese una granata e la gettò sotto a un’ambulanza tedesca. Morì un loro medico ufficiale e il ferito che stavano trasportando. L’altro ferito, quello buttato giù dalla scarpata, nonostante le ustioni e le fratture riuscì a fuggire, più morto che vivo raggiunse i suoi ufficiali.
Altri suoni di raffiche in lontananza raggiunsero il loro covo, altre sentinelle con in bocca l’appello dei fucilati scalarono l’appennino come scimmie.
- Fermatevi voi, che loro non lo faranno. Per un ammazzato dei loro muoiono 10 dei nostri. – Dicevano.
Fu a quel punto che Birillo, un ometto basso che girava per i boschi sempre scalzo, asfissiato dal fiatone aveva guardato Gustavo e gli aveva detto:
- Mi dispiace Cièncièn, si è saputo il tuo nome, hanno sparato alla tua pora
Poi tutto tacque, ma non c’era quiete, solo silenzio. Gustavo era scappato nel bosco per lasciarsi andare al pianto. Aveva ripensato al colpo sordo del suo schioppo puntato contro al ragazzo vestito di nero, che si era steso come se fosse coricato, improvvisamente zitto; subito dopo aveva abbassato il fucile e si era sollevata una brezza, i castagneti avevano frusciato all’unisono e lui si era illuso di aver raggiunto, con quel gesto, la schiettezza burbera che invidiava agli altri uomini, così come un tempo aveva fatto con il nonno. Quella durezza li faceva sembrare talmente eroici e disincantati. Aveva sperato di essere diventato magicamente come loro e che quello era il vero regalo che gli stavano facendo. Ma avrebbe dovuto capirlo subito, che era andata come con il coniglio. Gli avevano dato il vino da bere, una sigaretta da fumare e lui annuiva facendo finta di ridere, ma non poteva fare a meno di fissare i capelli corvini e lucidi del morto. Aveva pensato al momento in cui se li era pettinati, quella mattina, mentre era immerso nel Lamone. E adesso la mamma era morta, non era rimasto più nessuno ed era come se la guerra per lui fosse finita, perché era come se non facesse più parte del suo paese, né del mondo.
Aveva aspettato la notte, che non era arrivata abbastanza in fretta da evitargli il baratro del panico, un senso di morte profondo. Aveva pensato a Cecilia, Gualtiero, Susanna, Alfredo e quell’altra gente che certe domeniche gli aveva regalato il pesce e certe estati le risate e che era stata fucilata sul greto del fiume o arsa viva sui poderi dove stavano lavorando, solo per via del regalo inutile che non aveva chiesto, ma che si era preso. Aveva fatto finta di uscire per pisciare ed era fuggito giù dal monte. Correva e ruzzolava. Forse avevano ragione i poeti dei conigli morti, quelli che piangevano da soli in fondo alle osterie. Avrebbe dovuto scegliere la legione dei poeti e lasciare i macelli e le fucilazioni a quelli dell’altra schiera, agli schietti, gli indubbi. Adesso non avrebbe più potuto prendere parte a nessuna delle due fazioni. Il destino lo aveva punito per aver imbracciato l’arma che non gli corrispondeva. La poesia l’aveva persa per sempre, l’aveva venduta all’angoscia, premendo quel grilletto, calando quel bastone, illudendosi di poter essere altro. Inoltre, per quanto grande fosse il globo, a prescindere dalle distanze che sarebbe riuscito a mettere fra sé e quel suo compleanno, la sua culla era Marradi e lui l’aveva appena maledetta.
Punta verso casa sua, sotto sotto sperando che il ricognitore si fosse sbagliato e che sua mamma fosse ancora viva, pronta per aiutarlo. Ma spera anche di non aver più una madre, per non dover incrociare il suo sguardo, né confermarle quello che le voci le avevano riferito su di lui. La mamma era in casa fino a prima del tramonto. Lo aveva atteso per un mese, la sera posava i gomiti sui fornelli spenti e metteva la testa fuori dalla finestra della cucina. Guardava in su, verso il crinale.
Quel pomeriggio poi le avevano detto che era stato il suo Gustavo a iniziare tutto, a sparare al prigioniero. Le avevano riferito del regalo, dello sguardo del suo figliolo, che di quel dono aveva paura, che non sapeva cosa farsene, ma che poi aveva sparato.
- Ma non pensare che sia colpa sua, Giovanna, non lo devi pensare. Cièncièn è il più piccolino lassù e voleva farsi dentro nel gruppo. – Le avevano detto.
E poi tutti si erano nascosti perché c’erano in giro i lupi della rappresaglia. Avevano fatto fuori tutti. Lei era rimasta da sola. Continuava a ripetersi che in fondo non era stato il suo Gustavo a sparare ai civili, ai loro vicini, amici, non direttamente almeno. Pensava che i ragazzi avevano fatto bene a catturare quel fascista, ma non dovevano far finire il lavoro al ragazzo. Aveva mosso la mano nell’aria della cucina tenendo gli occhi chiusi e immaginando di accarezzargli la testa.
Tutti avevano iniziato a chiamarlo Cièncièn quando un sabato di mercato lo avevano visto correre emettendo uno strano suono metallico ogni volta che la suola della sua scarpa destra toccava il ciottolato. Gustavo non capiva da dove provenisse quel rumore e ogni tre passi arrestava la sua corsa improvvisamente per guardarsi attorno guardingo. Tutti gli avevano riso dietro, perché si erano accorti che aveva un chiodo infilato nel tacco, ma lui no, non lo sapeva e ogni volta che si voltava per capire da dove provenisse quel “cièn-cièn”, quel suono metallico, urlava: chi mi segue?
Il cuore di Giovanna si lacerava nell’immaginarlo lassù, sensibile com’era, che voleva vendicare i fratelli e il padre, accettare quell’assurdo regalo di compleanno, sperando magari di ricevere in premio una medaglia di legno o una caraffa di latte.
Poi la mamma aveva guardato in basso, verso il cortile, perché sentiva dei passi pesanti. Aveva visto i soldati arrivare e aveva capito che era finita. Gli era andata incontro, loro vedendola apparire sulla soglia di casa le avevano chiesto nome, cognome e una foto del figlio, ma lei senza rispondere gli aveva superati e si era incamminata tranquillamente in direzione della piazza, oltrepassando il cancello. Uno di loro aveva caricato la mitraglia e l’aveva colpita con una raffica alla schiena, i colpi l’avevano raggiunta mentre sorrideva rivolta al monte, trapassandola, aprendole il ventre e lo sterno. Dal petto le si erano librate le anime dei suoi amori, da lei protette e preservate.
Gustavo arriva fuori casa, è tutto ferito, fradicio, strappato, con le dita di una mano girate in modo strano, con la morte in gola che è un pianto sommesso e lo spavento incontenibile negli occhi, infossati nel cranio come quelli di una maschera demoniaca. Vede le zoccole di legno della mamma rovesciate sul vicolo, appena fuori dal cancello. Vede una chiazza di sangue, dei resti. Gli pare che quei brandelli di sua mamma vogliano soltanto strisciare via, nascondersi sotto alle felci del bosco e trovare la pace di un lutto. Allora corre a raccoglierli, sono gelidi e viscidi, c’è la pelle, ci sono ossa e viscere, li butta nel prato e pensa che così, almeno, serviranno ai vermi, alle formiche. Raccoglie anche le zoccole e le posa ordinate appena dentro al cancello. Poi si morde le nocche ferocemente, con i denti sporchi di melma.
In quel momento sente di essere diventato un uomo, ma non capisce di che tipo. Pensa a tante cose, fra le quali albeggia la paura di essere pazzo. Crede che i tedeschi e i fascisti lo stiano cercando, che gli sbandati lo giudichino un un traditore. Scende in cantina, si prepara un giaciglio. Con un vecchio martello spacca delle assi, sotto le assi c’è la terra viva del sottosuolo, continua a colpire creando una fossa dove infilarsi. Sarebbe rimasto nascosto fino al giorno in cui la guerra sarebbe finita, forse gli americani sarebbero davvero arrivati presto, ma in quel buco sarebbe stato pronto a morirci di stenti. In un altro punto della cantina creò un’altra buca, quando quella buca si sarebbe colmata dei suoi escrementi, pensò, l’avrebbe ricoperta e ne avrebbe scavata un’altra.
Si benda la mano, si disinfetta le ferite con la grappa e poi inizia a nutrirsi con tutto quello che trova in casa. La mamma quel giorno aveva cucinato, forse perché era il suo compleanno. Scopre in poche ore che c’è qualcosa di incolmabile in lui, che nessun pane inzuppato nella minestra di patate potrà riempire. Se ne sta lì sdraiato a guardare i mattoni del soffitto della cantina, per giorni, settimane, i pensieri diventano immobili, la melma gli imbratta l’anima. In un paio di settimane esaurisce le esigue scorte di cibo ammuffito, rosicchiato dalle arvicole. Inizia a bere il vino e la grappa che trova sugli scaffali. Ingolla una mezza bottiglia al giorno, solitamente prima di mezzogiorno. Il pomeriggio cerca di dormire e la sera si alimenta a grappa. Le budella gli bruciano, lo stomaco si contrae e sente che vorrebbe uscirgli dal corpo. Trascorre altre due settimane sdraiato, ubriaco fradicio e delirante, comincia a prepararsi alla propria morte. Immagina di infilarsi del tutto sotto alle assi e di sparire senza nemmeno un funerale. Nel tempo di mezza generazione tutti si sarebbero dimenticati che era esistito, il pensiero lo acquietava. È la fine di settembre quando due soldati entrano nella casa. Gustavo è emaciato, privo di forze vitali, in quel momento sta bevendo da sdraiato, sente i passi e cerca di sparire nella fossa. Sono due uomini armati e in uniforme quelli che discendono i gradini di legno e raggiungono il suo rifugio purgatorio. C’è un intenso odore di escrementi e alcol.
Gustavo li vede e loro vedono lui. Sono in due, la loro pelle ha il colore dei marroni del bosco, hanno occhi orientali e dai loro sorrisi spiccano dentature di un bianco sfavillante. Si muovono verso di lui e uno dei due gli tende la mano. Guerrino rimane immobile. Gli sembrano due pantere da sogno, con una mano cerca di fare leva sul pavimento, con l’altra si strofina gli occhi. Pensa di dire qualcosa ma non gli viene in mente nulla. Non è neppure sicuro che le due pantere umane esistano davvero. È come un animaletto braccato, un coniglio. Prova a tirarsi su ma sente le gambe molli e un formicolio al basso ventre. Sviene ricadendo nella fossa. I due soldati, che sono indiani e militano nelle truppe britanniche, fanno un balzo in avanti e lo sollevano. Si guardano attorno straniti e diranno in seguito, nei loro rapporti, che di quel giovane credettero che, a occhio e croce, non potesse far altro che morire.
Trascorrono diverse ore prima che Gustavo riprenda i sensi. Apre gli occhi e si sente ballonzolare su qualcosa di morbido. È sul rimorchio di un camion, sdraiato su una branda, le due pantere oniriche non ci sono più. Si mette a sedere facendo leva sulla balaustra che è al suo fianco, riuscendo a guardare oltre. Riconosce il paesaggio appenninico, ma non la località. Un altro soldato, pallido e biondo, lo raggiunge e gli posa una mano sulla fronte. Guerrino cerca di scorgere lo stemma sulla sua uniforme, non ci riesce perché il petto dell’uomo è troppo vicino al suo volto, però vede che sul rimorchio, insieme a lui, ci sono altre persone distese, alcune esanimi, altre come intorpidite. Ci sono anche polli, casse di munizioni, una capra e due neonati in fasce posati sul pianale, di cui uno gli sembra morto, immobile e azzurrino come certe albe domenicali di novembre.
- Dobbiamo andare to Florencia. Ospedale e tutto bene. You fortunato. – Gli dice gentilmente il militare con accento inglese.
- Le pantere a Marradi non si erano mai viste. – Bisbiglia Gustavo.
Chiude gli occhi e non riesce a far altro che addormentarsi di nuovo, sfinito da qualcosa che non sa. Prima di svanire nel sonno ripensa a tutto quello che era successo, ricordandosi che nulla, nemmeno un dettaglio, eppure gli era chiaro di trovarsi in un incubo. Non pensa, non sa. Non ha fame di nulla, avrebbe solo voglia di mordere altro fango e ingollare un altro sorso di grappa. “Terra e fuoco, devo essere un diavolo.” Pensa. Poi crolla.
